Pubblicato anche su Ibridamenti.com
Attendevo “Lo schizofrenico della famiglia” di Pietro Barbetta con una certa curiosità, per almeno tre ragioni.
La prima ragione è che da anni Pietro illustrava le idee e raccontava le storie cliniche che ora sono raccolte nel volume. Credo infatti che fra i suoi libri questo sia stato quello che più ha dovuto lottare per arrivare negli scaffali: per via, dice l’autore, di una “tendenza del mercato psi a non parlare di schizofrenia se non in relazione al trend che va di moda: neurotrasmettitori e cervella“. Tributiamo dunque una gioiosa ola all’editore Meltemi, cui va dato atto di averlo voluto nel proprio catalogo.
In un affollato seminario a Milano nel 2007, ad esempio, Barbetta accese il dibattito con la sua idea che la schizofrenia stesse conoscendo una specie di mutazione, dai floridi deliri a cui ci aveva abituati fino a qualche anno fa al minimalismo catatonico dei “sintomi negativi”, che sono il prodotto dei nuovi neurolettici atipici.
Terapeuta familiare nel solco del pensiero sistemico e della complessità, discendente del “Milan Approach” di Luigi Boscolo eGianfranco Cecchin, Pietro Barbetta ha una sua tendenza a guardare quello che non è così ovvio ma che pure è rilevante: come per esempio il contesto, quello sfondo trascurato che fa parte del “rimosso” dell’“inconscio psichiatrico”.
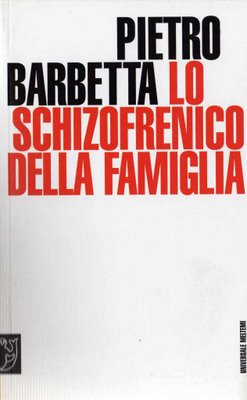 Detta così pare quasi un’ovvietà; eppure, se è banale dire che nella nostra cultura un raffreddore non è quello di duecento anni fa – perché ad un certo punto della sua storia clinica oggi entra “naturalmente” l’acido acetilsalicilico con i suoi effetti chimici -, non riusciamo a trovare altrettanto evidente che la storia clinica di un caso di schizofrenia non possa prescindere dalla psichiatria e dai suoi effetti chimico relazionali. Rimozione, dice Barbetta, che era ancora più massiccia prima di Bateson, Deleuze e Foucault: come risultato, l’unica spiegazione vera della malattia mentale era quella di tipo medico, individuale, a-contestuale.
Detta così pare quasi un’ovvietà; eppure, se è banale dire che nella nostra cultura un raffreddore non è quello di duecento anni fa – perché ad un certo punto della sua storia clinica oggi entra “naturalmente” l’acido acetilsalicilico con i suoi effetti chimici -, non riusciamo a trovare altrettanto evidente che la storia clinica di un caso di schizofrenia non possa prescindere dalla psichiatria e dai suoi effetti chimico relazionali. Rimozione, dice Barbetta, che era ancora più massiccia prima di Bateson, Deleuze e Foucault: come risultato, l’unica spiegazione vera della malattia mentale era quella di tipo medico, individuale, a-contestuale.
Dicevo di tre ragioni per le quali attendevo “Lo schizofrenico”: la seconda è che confidavo che mi chiarisse la direzione che sta prendendo il pensiero di Barbetta sulla diagnosi. Sapevo che da anni stava lavorando sui temi delle categorie diagnostiche (uno dei suoi libri precendenti è il denso “Anoressia e isteria”), e conoscendolo come un esponente di una scuola di pensiero che alla bussola sicura della diagnosi preferisce le vicissitudini dell’ipotizzazione continua, qualcosa del suo percorso continuava a restarmi misteriosa.
Ora vi dico come l’ho capita io.
Una delle “vacche sacre” della psicoterapia (recupero una felice espressione di Lynn Hoffman) è l’idea che non si possa fare un’adeguata terapia senza partire da una diagnosi puntuale. Non voglio insistere sul fatto che questa premessa ricalca pari pari la premessa medica trasportandola meccanicamente (e incautamente) in un altro territorio: ma sul fatto che, nella cura psicologica, questo è uno dei miti più proclamati e insieme più contraddetti (inconsapevolmente, perché poi nella pratica clinica c’è sempre molto di più di quello che ci raccontiamo; oppure deliberatamente, nella separata sede delle conversazioni fra professionisti e nella corrispondenza in mailing list private).
La differenza fra il pensare alla diagnosi come una punteggiatura che contribuisce a costruire la cultura che l’ha generata e il pensarla come conoscenza “esatta” della realtà, ha a che fare con la rimozione del contesto e dell’osservatore.
Nei casi raccontati qui, la diagnosi non è più la necessaria preconoscenza a partire dalla quale inizia il dialogo terapeutico: non sta prima e a monte di quello, ma nella sua cornice. Come nella “Galleria di stampe” di Escher, il contesto entra nella storia e la storia fa da contesto al contesto. Il paziente psichiatrico, conversando col terapeuta sulla diagnosi, ritorna individuo, persona, anziché malato. Partecipa a un salto logico: se lui non è più “dentro” la diagnosi, ma è la diagnosi che sta “dentro” la sua conversazione col terapeuta, non è la patologia che lo governa, ma è lui che la governa dicendola, parlandone, condividendo con i professionisti della salute una competenza e una moral agency.
E la terza ragione? La terza è che Pietro è un irresistibile narratore di storie cliniche. Scommetto che le vicende di Giacobbe, di Gianmaria, di Matteo e Giulietta si avvieranno a diventare piccoli classici della letteratura psicoterapeutica, di quelle storie che illuminano la ricerca di una via pragmatica e clinicamente credibile fra la Scilla dell’universo concentrazionario psichiatrico e la Cariddi del riduzionismo sociologico antipsichiatrico.
